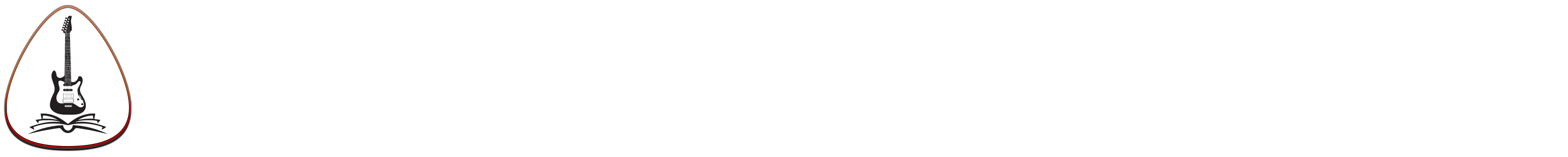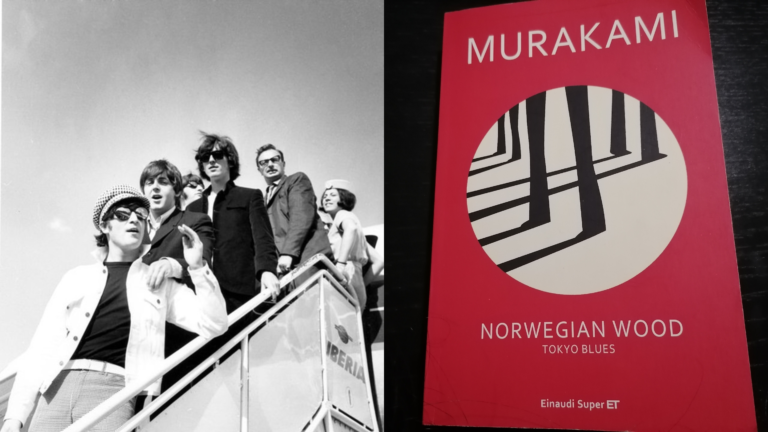Wunderhorse: c’è ancora speranza in questo mondo (rock)
Un paio di anni fa Jacob Slater ha recitato nella parte del batterista Paul Cook in “Pistol“,…
Un paio di anni fa Jacob Slater ha recitato nella parte del batterista Paul Cook in “Pistol“, la miniserie diretta da Danny Boyle e dedicata proprio alla nascita, all’irruenza e all’influenza dei Sex Pistols.
Come se non fossero sufficienti le parole “Pistols” e “Danny Boyle” per attirare l’immediata attenzione di chi scrive su Slater, ecco che lui, sornione, rifila il tocco di grazia: è anche un cantautore ed è il frontman di una delle band più fighe del momento.
Ma quindi chi è Jacob Slater? Qual è la sua band? E perché è così interessante?

Jacob Slater è un musicista londinese che sa alternare una voce intimistica e acustica, quella del suo cantautorato solista, al fragore delle chitarre distorte della sua band, i Wunderhorse.
E’ un ventisettenne sfrontato che, prima, ha fondato una band punk, i Death Pretties, e che poi, durante la solitudine della pandemia Covid, ha deciso di avviare il suo progetto musicale solista, traendo ispirazione per il nome da uno show televisivo degli anni ’40 – “Champion the Wonder Horse” – e trasformandolo con nonchalance in uno dei progetti più interessanti dell’alternative rock contemporaneo (tradotto: uno dei pochissimi progetti che ancora riescono a dare linfa vitale a una scena stanca, fatta di band tutte uguali e con poco da dire).
E’ stato proprio al concerto di un’altra band “salvifica” per questo genere musicale, i Fontaines D.C., che siamo incappati – prepotentemente – nei Wunderhorse.
No, non sono parole a caso: in soli due album, i Wunderhorse hanno creato un piccolo repertorio di pezzi incredibili, che alternano melodie immediatamente orecchiabili e a tratti quasi folk-pop, come la riuscitissima “Purple”, alla voce disperata di “Teal” e alle atmosfere sofferenti di “Arizona” e “Aeroplane” o, ancora, ai tocchi grunge di “Silver” ed “Emily“.
Non stupisce, insomma, che, fin dal loro debutto discografico, i nostri abbiano ricevuto recensioni pazzesche da alcune delle più autorevoli testate musicali del settore – NME, Riot e Far Out – che hanno parlato di “un disco che scalda l’anima” e delle “canzoni rock meglio realizzate e più interessanti di questo decennio“.
Lo scorso agosto, l’uscita della seconda fatica, “Midas“, non ha fatto altro che confermare la curva crescente di riconoscimento della band, impreziosita dai tour internazionali con Fontaines DC, Pixies, Foals, Sam Fender e Declan McKenna.

Ma cosa ha permesso ai pezzi dei Wunderhorse di arrivare così direttamente a critica e persone?
La domanda sorge spontanea, perché va sottolineato come, al di là delle recensioni entusiaste, l’attenzione e il silenzio calati sul pubblico dell’Alcatraz di Milano durante il loro live siano stati a dir poco stupefacenti.
La ricetta è tanto semplice a dirsi, quanto rara da trovare nella scena del cosiddetto e mal definito “indie-rock”: testi crudi e intensi che descrivono dissidi interiori, amori sofferti, dipendenze, perdite e vulnerabilità, uniti ad atmosfere sonore che riflettono i paesaggi emotivi dell’abbandono, delle insicurezze, della passione e della debolezza.
Non è difficile capire come certe sensazioni possano trovare facile aderenza nel vissuto di tante persone, viaggiando tra generazioni diverse.
Jacob Slater è un cantautore e, che si tratti di un pezzo intimista o di chitarre distorte, a tessere le trame delle sue canzoni è un unico e imprescindibile ago, preciso e pungente: la parola.
I testi comunicano una rassegnazione al dolore emotivo, come in una sorta di accettazione silenziosa che, però, si contrappone al desiderio di cambiamento: ecco quindi che si alternano in rapida successioni momenti di impotenza e frammenti di speranza.
Da una canzone all’altra, insieme ai Wunderhorse ci si sposta dall’angoscia esistenziale – “I’ve always known an anger and I’ve always known a shame, I felt it like a hunger before I knew my name, I’m just an empty promise with nothing much to say” (“Silver”) – a semplici sprazzi di candida rinascita: “I got an aeroplane in my backyard, it’s been grounded for some time, broken wings and busted windows, won’t you come and make it fly?” (“Aeroplane”).
Il tutto senza dimenticare il disagio e le difficoltà delle interazioni personali che, nonostante vengano messe nero su bianco da un ragazzo neanche trentenne, trovano vivido appiglio anche in chi ha una o due decadi in più sulle spalle: “Some people have a special kinda knack, getting what they wanted just to stab you in the back, nine times out of ten it’s the leader of the pack” (“Leader of the Pack”).
Una menzione speciale, infine, merita il contrasto aspro e potente raccontato in maniera magistrale dal testo di “Cathedrals“, una delle tracce dell’ultimo album: la bellezza incastonata nel dolore e la sofferenza che si trasforma in stupore:
“There are shipwrecks in the sea,
There are blossoms on the tree,
There’s this little part of me that is you,
There are horses all in flames,
They go racing down my veins
There is beauty inside pain,
Inside you”
Perché, forse, è proprio così che ci lascia la vita: impotenti e impauriti davanti all’altezza austera di una cattedrale gotica e al vuoto evocato dai suoi spazi, ma inebriati dalla bellezza dirompente di un raggio di luce che può frangersi improvvisamente in una delle sue vetrate, colorando il buio con inaspettati e magici giochi di colore.
Visto? E’ proprio così che ci si sente ascoltando i Wunderhorse.
Provare per credere: forse ne uscirete un po’ ammaccati emotivamente, ma avrete realizzato che c’è ancora speranza per la bellezza.
Nella musica, come nella vita.
Sara Bernasconi